
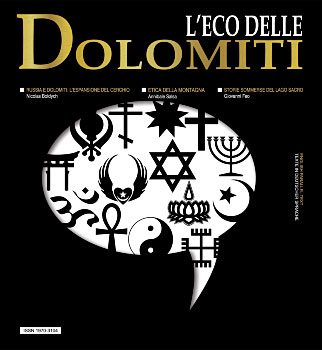
ETICA DELLA MONTAGNA
Annibale Salsa

Nella nostra epoca di crisi, sia dei valori tradizionali legati a passate epoche storiche, sia dell’etica naturale fondata su valori universali non negoziabili, ci interroghiamo con ansia crescente su quali potrebbero essere gli ingredienti con cui costruire nuove piattaforme etiche. E dobbiamo farlo ricorrendo a linguaggi facilmente accessibili ai giovani. In tal senso, la montagna ci può soccorrere anche di fronte agli scenari imprevedibili del postmoderno. La montagna è stata per gli uomini, e può continuare a esserlo tuttora, la grande metafora della vita. Per questa sua “vocazione”, talvolta declinata in chiave retorica, ha fornito alle culture umane la base materiale per elaborare simboli forti attraverso le grandi narrazioni mitologiche e religiose dell’antichità (miti, leggende, tradizioni orali).  Dalle rappresentazioni silvestri, a sfondo panteista, del mondo pagano fino alle grandi “religioni del libro”, a carattere universale e monoteistico (giudaismo/cristianesimo/islamismo), l’icona della montagna sacra e inviolabile è riuscita a comunicare il suo ruolo di tramite fra la “città terrena” e la “città celeste”. Intorno a un simbolo così forte si intersecano e si sovrappongono fattori di diversa natura, efficaci nel fornire le basi di un’etica materiale e immateriale dei valori. Al primo posto vi è il tema del limite che, in una società tecnocratica sedotta dalle performances della “cultura della fretta” e del no limits, può costituire un’efficace provocazione in senso etico. Uno dei grandi mali morali che la nostra società liquida della comunicazione continua ad alimentare, soprattutto per la facilità di persuasione occulta svolta dai media, è rinvenibile nella spinta al superamento di qualsiasi limite, sia esso di natura fisica, sportiva, tecnica, economica, finanziaria. Ogni cosa e ogni esperienza vengono misurate secondo i parametri quantitativi della ragione calcolante, senza essere sottoposte al severo tribunale della coscienza morale. La tecnologia mette a disposizione i suoi efficienti strumenti di dominio e di superamento dei limiti inculcando, negli uomini del nostro tempo, deliri crescenti di onnipotenza dagli effetti esiziali.
Dalle rappresentazioni silvestri, a sfondo panteista, del mondo pagano fino alle grandi “religioni del libro”, a carattere universale e monoteistico (giudaismo/cristianesimo/islamismo), l’icona della montagna sacra e inviolabile è riuscita a comunicare il suo ruolo di tramite fra la “città terrena” e la “città celeste”. Intorno a un simbolo così forte si intersecano e si sovrappongono fattori di diversa natura, efficaci nel fornire le basi di un’etica materiale e immateriale dei valori. Al primo posto vi è il tema del limite che, in una società tecnocratica sedotta dalle performances della “cultura della fretta” e del no limits, può costituire un’efficace provocazione in senso etico. Uno dei grandi mali morali che la nostra società liquida della comunicazione continua ad alimentare, soprattutto per la facilità di persuasione occulta svolta dai media, è rinvenibile nella spinta al superamento di qualsiasi limite, sia esso di natura fisica, sportiva, tecnica, economica, finanziaria. Ogni cosa e ogni esperienza vengono misurate secondo i parametri quantitativi della ragione calcolante, senza essere sottoposte al severo tribunale della coscienza morale. La tecnologia mette a disposizione i suoi efficienti strumenti di dominio e di superamento dei limiti inculcando, negli uomini del nostro tempo, deliri crescenti di onnipotenza dagli effetti esiziali. 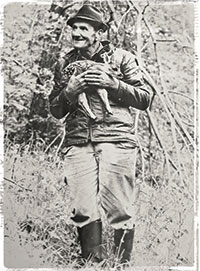 Tutto diventa possibile e permesso. Ogni barriera è superabile, da quella della fatica a quella della conoscenza. A questo punto, un equilibrato avvicinamento alla montagna può rappresentare una provvidenziale scuola di vita, soprattutto per le giovani generazioni. Scriveva Goethe che le montagne sono maestre severe che generano discepoli silenziosi. E il silenzio costituisce l’essenza profonda del linguaggio della montagna. Un silenzio il cui “rumore” oggi produce disagio, disorientamento, spaesamento. Il filosofo di Friburgo Martin Heidegger, nella sua baita della Foresta Nera, aveva sperimentato di persona che il silenzio, come la poesia, sono linguaggi estremi. Essi, infatti, consentono di dire ciò che il linguaggio discorsivo non è in grado di comunicare: il modo di essere autentico nel mondo. La montagna rispettata è un luogo in cui la natura elargisce il massimo dei suoi effetti benefici, sia sul piano fisico che su quello mentale. Anzi, essa aiuta a superare quel dualismo tra mente e corpo che, a minori altezze, rende la vita quasi schizofrenica e alienante. La montagna possiede un intrinseco valore terapeutico nel momento in cui ci separa dalla realtà inautentica della quotidianità e ci aiuta a scoprire noi stessi, mettendoci al cospetto delle profondità del nostro io, senza menzogne o infingimenti, senza le griglie convenzionali della falsa coscienza. Allora, molte precarie difese psicologiche denunciano la loro fragilità. A beneficiarne sono la solidarietà e la coesione sociale quali antidoti a forme patologiche di individualismo egoistico. Nella sfida alle difficoltà della vita l’habitat montano alimenta quello spirito di cordata che la società utilitaristica intenzionalmente rimuove.
Tutto diventa possibile e permesso. Ogni barriera è superabile, da quella della fatica a quella della conoscenza. A questo punto, un equilibrato avvicinamento alla montagna può rappresentare una provvidenziale scuola di vita, soprattutto per le giovani generazioni. Scriveva Goethe che le montagne sono maestre severe che generano discepoli silenziosi. E il silenzio costituisce l’essenza profonda del linguaggio della montagna. Un silenzio il cui “rumore” oggi produce disagio, disorientamento, spaesamento. Il filosofo di Friburgo Martin Heidegger, nella sua baita della Foresta Nera, aveva sperimentato di persona che il silenzio, come la poesia, sono linguaggi estremi. Essi, infatti, consentono di dire ciò che il linguaggio discorsivo non è in grado di comunicare: il modo di essere autentico nel mondo. La montagna rispettata è un luogo in cui la natura elargisce il massimo dei suoi effetti benefici, sia sul piano fisico che su quello mentale. Anzi, essa aiuta a superare quel dualismo tra mente e corpo che, a minori altezze, rende la vita quasi schizofrenica e alienante. La montagna possiede un intrinseco valore terapeutico nel momento in cui ci separa dalla realtà inautentica della quotidianità e ci aiuta a scoprire noi stessi, mettendoci al cospetto delle profondità del nostro io, senza menzogne o infingimenti, senza le griglie convenzionali della falsa coscienza. Allora, molte precarie difese psicologiche denunciano la loro fragilità. A beneficiarne sono la solidarietà e la coesione sociale quali antidoti a forme patologiche di individualismo egoistico. Nella sfida alle difficoltà della vita l’habitat montano alimenta quello spirito di cordata che la società utilitaristica intenzionalmente rimuove.

 Nell’attuale Europa senza frontiere e di fronte allo spettro degli irresponsabili euroscetticismi oggi di moda, non si dovrebbe perdere l’occasione per fare chiarezza, serenamente e pacificamente, sulla distinzione inequivocabile fra invasori e difensori, fra occupanti e occupati. Anche in questi casi, la lezione del limite può rappresentare un ammonimento pedagogico, educativo, nell’insegnare ai giovani a guardare in faccia la realtà, con i piedi per terra dei vecchi montanari, senza i filtri delle ingannevoli costruzioni ideologiche. Il “mito di Icaro”, cioè la spinta fisica, mentale e spirituale al trascendimento della dimensione orizzontale dovrà, quindi, essere accompagnata da un’etica della responsabilità verso la natura e verso noi stessi.
Nell’attuale Europa senza frontiere e di fronte allo spettro degli irresponsabili euroscetticismi oggi di moda, non si dovrebbe perdere l’occasione per fare chiarezza, serenamente e pacificamente, sulla distinzione inequivocabile fra invasori e difensori, fra occupanti e occupati. Anche in questi casi, la lezione del limite può rappresentare un ammonimento pedagogico, educativo, nell’insegnare ai giovani a guardare in faccia la realtà, con i piedi per terra dei vecchi montanari, senza i filtri delle ingannevoli costruzioni ideologiche. Il “mito di Icaro”, cioè la spinta fisica, mentale e spirituale al trascendimento della dimensione orizzontale dovrà, quindi, essere accompagnata da un’etica della responsabilità verso la natura e verso noi stessi.